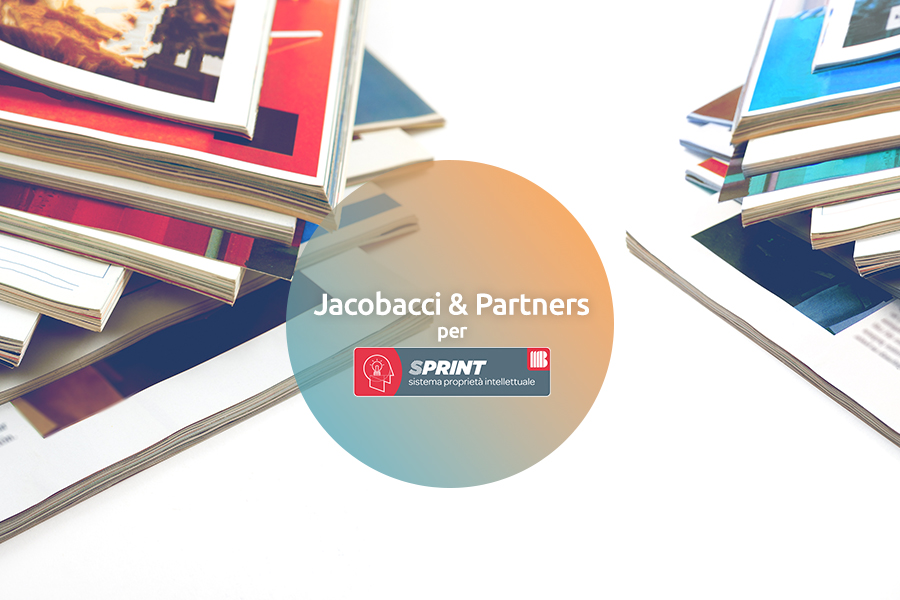Dal momento che il confronto sulla politica energetica in Italia è spesso guidata da visioni ideologiche, abbiamo deciso di sviluppare un confronto tra due esperti Marco Enrico Ricotti, Professore Ordinario di ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano e Attilio Piattelli presidente del coordinamento Free (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) ponendo delle domande aperte con l’idea di evidenziare i punti di forza e le eventuali debolezze di tutte le soluzioni in campo. Il punto di partenza è quindi che non esistono soluzioni preconfezionate, e che non esistono nemmeno soluzioni necessariamente migliori di altre . Esistono però soluzioni più adatte a rispondere alle domande che si pongono e agli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Lo scenario energetico europeo e una visione sui trend in corso. Dal vostro punto di vista dove siamo, qual è il punto di partenza?
Attilio Piattelli
L’Europa ha sempre avuto un ruolo fondamentale sulle politiche di decarbonizzazione avendo intrapreso questo percorso già da anni, con politiche di decarbonizzazione molto precise e con target di abbattimento delle emissioni che via via sono divenuti sempre più ambiziosi. Ritengo che abbia rappresentato un modello per il resto del mondo. Un grave errore che però si è fatto nel corso di questi anni è che si è trascurato di accompagnare le politiche di decarbonizzazione con politiche di supporto allo sviluppo di una filiera industriale green. Oggi questa carenza sta pesando poiché le aziende europee impegnate nei settori green sono rimaste indietro rispetto alla concorrenza dell’industria cinese, che invece ha attuato politiche industriali di supporto e stimolo molto precise e stabili nel tempo. Ora a livello europeo si sta assistendo a ipotesi di rallentamento e/o parziale ripensamento sulle politiche di decarbonizzazione ma, a mio parere, sarebbe un ulteriore autogol per l’Europa perché rischierebbe di rallentare ulteriormente la riconversione green del sistema produttivo europeo. Servirebbero invece politiche industriali comuni di rilancio di tutti i settori innovativi con il supporto di un fondo comune europeo dedicato alla Transizione Energetica, come proposto dal Rapporto Draghi.
Marco Enrico Ricotti
Il punto di partenza è quello riportato in figura 1 (dati 2024): il nucleare europeo, con i suoi 100 reattori in funzione, rappresenta ancora la prima fonte per la produzione di energia elettrica del continente, anzi la prima fonte decarbonizzata, che in aggiunta è anche la fonte a minore dipendenza strategica da altri paesi (non così si può dire né per le fossili né per le rinnovabili) nel 2024, poi, la Francia (70% di elettricità da nucleare) ha esportato 89 TWh verso Italia (52 TWh) e Germania (28 TWh), due nazioni che non hanno il nucleare e che hanno i prezzi dell'elettricità ben superiori a quelli francesi. Se poi consideriamo tutta l'energia, non solo l'elettricità, allora il percorso dell'Europa è ancora molto più lungo, perché per l'80% circa l'energia dipende dai fossili. In questo scenario così impegnativo, contrapporre nucleare e rinnovabili è una battaglia di retroguardia, già persa in partenza: serve sfruttare al meglio tutte le fonti, in particolare le due decarbonizzate, ma bisogna considerare anche la geopolitica e la competitività industriale.

Decarbonizzazione senza nucleare. Il nucleare tradizionale ha fornito energia a basse emissioni per decenni e quello di nuova generazione promette di essere ancora più efficiente, ma lo è davvero? Se lo escludiamo completamente, possiamo realisticamente eliminare le fonti fossili senza rischiare problemi di stabilità della rete o dipendenza da soluzioni ancora in evoluzione?
Marco Enrico Ricotti
Che il nucleare sia efficiente ed efficace (anche più del solare fotovoltaico) dal punto di vista delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente - terre rare, utilizzo di suolo, etc. - lo riconosce anche l'IPCC e il Joint Research Centre Europeo,
non capisco perché dovrebbe essere messo in discussione: ci sono evidenze tecniche-scientifiche in tal senso? se qualcuno le ha, le mostri. Perché mai dovrebbe essere escluso completamente il nucleare? Chi lo ha deciso? È stato riconosciuto anche nella Green Taxonomy europea e i dati mostrati parlano chiaro: sarebbe da pazzi per l'Europa abbandonarlo, basta vedere il risultato della decisione tedesca di abbandonare le proprie 14 centrali nucleari: hanno una delle emissioni di CO2 per kWh prodotto più alte d'Europa, seconda solo alla Polonia, e per sopperire alla mancata produzione hanno dovuto riaprire vecchie centrali a lignite, che sono peggio di quelle a carbone, dalle quali comunque ottengono oltre il 25% dell'elettricità domestica. Non mi pare un esempio da seguire che poi in una rete con forte presenza di rinnovabili i problemi di gestione siano maggiori, lo dicono i gestori delle reti europee.
Attilio Piattelli
Il nucleare è una tecnologia di generazione che poco si presta alla modulazione ed è quindi sempre stata una fonte di generazione cosiddetta di “baseload” su cui poi sopra si possono aggiungere rinnovabili e generazione da cicli combinati a gas per la modulazione dei picchi di generazione e di domanda. Oggi, in molti paesi europei lo scenario è completamente cambiato e la generazione di baseload è fatta dalla diffusione di tante rinnovabili, che sono divenute nel tempo tecnologicamente molto affidabili e anche economicamente molto convenienti (soprattutto eolico e fotovoltaico). Non serve quindi tecnicamente inserire una fonte di generazione continua ma serve inserire nel sistema elettrico i sistemi modulanti. Fino ad oggi, come già detto, la modulazione è stata fatta con i cicli combinati a gas ma, con l’evoluzione tecnologica dei sistemi di accumulo elettrochimici e la fortissima riduzione dei costi, oggi questa modulazione può essere fatta agevolmente sul breve dalle batterie. Servono invece ancora sforzi sulla messa a punto di sistemi di accumulo di media durata (fino alla settimana) e di lunga durata per gli accumuli stagionali, che in via transitoria possono essere parzialmente sostituiti da una recente soluzione innovativa: mix eolico/fotovoltaico, supportato da accumuli e demanda response, che garantiscono fornitura di energia 24 h/7 su 7. Quindi, volendo riassumere, oggi non c’è una carenza di generazione elettrica priva di emissioni, su cui il nucleare si potrebbe inserire ma una necessità di gestione dell’accoppiamento della generazione e della domanda su cui si inseriscono gli accumuli elettrochimici e i pompaggi ma che ad oggi rende ancora necessari in alcuni momenti l’uso dei cicli combinati, capaci di modulare con estrema flessibilità. A lungo termine, rinnovabili, accumuli e potenziamento delle interconnessioni elettriche internazionali rappresenteranno le soluzioni definitive per una generazione 100% rinnovabile.

Il nucleare tradizionale ha reso alcuni paesi più indipendenti, ma richiede uranio, spesso importato. Le rinnovabili riducono la dipendenza dai combustibili fossili, ma necessitano di tecnologie che dipendono da materie prime strategiche come litio, cobalto e terre rare, spesso controllate da pochi paesi. Quale delle due opzioni è più sostenibile a lungo termine senza creare nuove dipendenze geopolitiche?
Attilio Piattelli
Credo si debba tornare alla domanda precedente e chiedersi se sia necessario uno scenario per l’Italia che preveda il nucleare e poi fare le valutazioni strategiche sulla criticità degli approvvigionamenti. A mio parere lo scenario nucleare per l’Italia, per quanto detto in precedenza, per i problemi che la tecnologia non ha ancora risolto e per i costi che ad oggi sono sensibilmente superiori alla generazione da rinnovabili, non sarebbe logico. Quindi la domanda sulla delicatezza degli approvvigionamenti dovrebbe essere legata a quella se la tecnologia serve oppure no. In ogni caso, volendo rispondere e per necessità di sintesi, non potendo affrontare il problema in modo esaustivo, mi limito a dire che l’approvvigionamento di uranio è richiesto con continuità per far funzionare le centrali visto che rappresenta il suo combustibile, il litio il cobalto e le terre rare servono per la produzione di componenti che però, una volta acquistati, durano per decine di anni e permettono di produrre o di stoccare energia senza la necessità di approvvigionamenti ulteriori. Quindi per il nucleare il combustibile è indispensabile per il funzionamento mentre per le rinnovabili e gli accumuli i materiali strategici sono necessari solo per l’eventuale incremento di potenza di generazione. Inoltre, la Commissione europea ha varato un programma con tre obiettivi: estrazione di materiali critici e strategici dai giacimenti esistenti in Europa e riuso e riciclo di quelli presenti nei componenti a fine vita. Sulla scala delle criticità, direi pertanto che il nucleare è certamente più a rischio.
Marco Enrico Ricotti
L'Europa domina l'intera catena del valore sulla filiera nucleare, dalle miniere (la Francia possiede in comproprietà la più "ricca" miniera di uranio al mondo, Cigar Lake in Canada) all'arricchimento del combustibile, alla sua fabbricazione, alla progettazione, realizzazione e gestione dei reattori, sino allo smantellamento e alla gestione dei rifiuti radioattivi, incluso il primo e unico deposito geologico profondo per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti ad alta radioattività (in Finlandia, ad Onkalo, aprirà nel 2026). Storicamente, l'uranio naturale è stato sempre acquistato all'estero perchè non vogliamo "scavare" in casa nostra (esempio vicino a noi: nella bergamasca esiste una miniera di uranio che gli australiani volevano sfruttare già nel 2006, ma glielo abbiamo impedito), comunque possiamo "dipendere" da paesi non critici quali Australia e Canada, che hanno le maggiori riserve al mondo, sia per le tecnologie sia per i materiali critici e le terre rare, purtroppo, mi pare che per le rinnovabili la situazione non sia la medesima (figura 2): il monopolio è saldamente nelle mani della Cina (sono fallite in Europa le principali aziende che si occupavano di produrre pale eoliche e batterie per l'accumulo).
Oggi in Italia utilizziamo energia nucleare importata da Francia e Svizzera. Se decidiamo di non investire nel nucleare, ha senso continuare a importare questa energia? Oppure dovremmo puntare su un'alternativa che ci garantisca maggiore indipendenza e controllo? Dall’altro lato, il nucleare ha emissioni quasi nulle in fase operativa, ma il ciclo di vita (estrazione, costruzione, smantellamento) ha un impatto ambientale e comporta costi di gestione importanti. Questo bilancio ambientale ed economico è paragonabile a quello delle rinnovabili, considerando anche le infrastrutture necessarie per il loro sviluppo?
Marco Enrico Ricotti
Importiamo in media da Francia e Svizzera il 15% dell'elettricità (essenzialmente da nucleare) che ci serve per vivere perché è più conveniente, è una questione economica e di mercato. Se decidessimo di dire no al nucleare in Italia, dovremmo essere coerenti e fare come i tedeschi, che hanno deciso di uscire dall'atomo a fronte dei risultati di una EtikKommission (commissione etica) la quale dichiarò che non era etico per la Germania né produrre né consumare energia elettrica prodotta col nucleare; sappiamo bene però com'è andata a finire. Il nucleare ha basso impatto ambientale sull'intero ciclo di vita, non solo sul funzionamento dei reattori: si legga al proposito il report di oltre 350 pagine prodotto dal Joint Research Centre dell'Unione Europea.
Attilio Piattelli
Credo che il vero problema della generazione da nucleare sia proprio quello che, nel corso di più di 70 anni di vita, non sono stati fatti passi avanti significativi su tutta una serie di problemi tecnologici che ne determinano la sicurezza, la capacità di gestione delle scorie e lo smantellamento a fine vita degli impianti. Infatti, da una generazione elettrica che nei primi anni duemila copriva circa il 17 % della produzione mondiale si è scesi oggi a circa il 9% e questo non è certo tipico di tecnologie in espansione. In questo scenario, mentre risulta poco comprensibile la scelta italiana di un ritorno al nucleare, è da ritenere del tutto logica la scelta cinese, o di altri paesi in forte crescita di consumi energetici, che hanno considerato l’opzione nucleare un’opzione per accelerare il processo di decarbonizzazione in abbinamento con un forte sviluppo anche delle rinnovabili (ma non dobbiamo farci ingannare dai grandi numeri, dovuti al fatto che la Cina è di fatto un subcontinente; in realtà il nucleare fornisce oggi solo circa il 5% dell’energia elettrica consumata in Cina). Per l’importazione di energia nucleare da Francia e Svizzera, non ne farei una questione ideologica, così come possiamo importare energia eolica dalla Germania o dai paesi nordici in caso di eccesso di produzione da eolico, non vedo perché non potremmo importare energia nucleare visto che le centrali sono già esistenti.
Il nucleare richiede anni per essere costruito, mentre le rinnovabili possono essere implementate più velocemente. Tuttavia, le rinnovabili sono limitate da fattori come vincoli burocratici, disponibilità di suolo e necessità di accumulo per garantire continuità. Possiamo davvero permetterci di aspettare lo sviluppo di accumuli energetici efficienti, o è più realistico avere una combinazione di nucleare e rinnovabili per garantire stabilità alla rete? Dall’altro lato se LCOE di questi impianti nucleari è pari a quello del FV+batterie, perché devo aspettare fino al 2040 per avere quei kWh?
Attilio Piattelli
Spesso si tende ad associare l’intermittenza della generazione da rinnovabili elettriche al nucleare come la possibile soluzione ma tecnicamente, come già detto in precedenza, il nucleare può generare energia di “baseload” ma non può modulare, cosa che invece fanno benissimo gli accumuli e i cicli combinati a gas. Questo vuol dire che fino a quando non avremo accumuli efficienti anche di lunga durata, continueremo ad aver bisogno di una certa disponibilità di cicli combinati a gas per la modulazione. Per quel che riguarda invece la disponibilità di spazi per le rinnovabili si tratta di un’amplificazione di un problema che proprio non esiste perché gli spazi necessari per una completa decarbonizzazione sarebbero comunque limitati. Così come l’amplificazione dell’impatto paesaggistico è esagerata visto che tutte le azioni dell’uomo nel tempo non hanno fatto altro che agire su continue modificazioni del paesaggio. In merito al LCOE ad oggi, anche in base ad alcuni studi internazionali (si richiama soprattutto l’ultimo report della IEA), l’LCOE di eolico on shore + accumuli e FV + accumuli è comunque inferiore a quello del nucleare.
Marco Enrico Ricotti
Qui servirebbero 3 pagine per rispondere a tutti i temi. I costi di sistema (alias rete di trasmissione e distribuzione, accumuli) aumentano esponenzialmente oltre il 70% di rinnovabili nella rete, come confermato dal Direttore del settore energia del MASE e da studi di scenario effettuati da alcune utilities italiane, quindi una percentuale di nucleare (il PNIEC prevede un 10-20% al 2050) non potrebbe che risultare benefico, sia per le tasche degli italiani (che dovrebbero pagare quei costi di sistema) sia per la penetrazione delle rinnovabili. Al nucleare va fornita la possibilità di esistere sul mercato, e non va trattato diversamente dalle rinnovabili, visto che decarbonizza e anzi riduce la dipendenza strategica europea, poi saranno le utilities e gli energivori, le industrie a decidere se è conveniente o meno. Alcuni sostengono che le rinnovabili siano intermittenti e non sufficienti, altri che il nucleare sottragga fondi a soluzioni più rapide e sostenibili. Entrambe le posizioni hanno punti di forza e criticità: quale delle due è più realistica per raggiungere emissioni zero in tempi utili? Ma soprattutto, una visione che veda un mix delle due soluzioni è davvero impensabile? O il problema principale è la mancanza di volontà politica e di risorse economiche sufficienti per accelerare la transizione?
Nessuno parla della qualità della domanda, cioè come venga effettivamente utilizzata questa energia, non sarebbe sensato lavorare/investire sull'educazione e su sistemi di incentivazione/tassazione (spinta gentile) per favorire consumi primari e disincentivare quelli non necessari?
Attilio Piattelli
Assolutamente si. L’investimento in una corretta informazione dovrebbe riguardare sia la formazione per un miglior uso dell’energia sia l’aumento di consapevolezza sulla necessità e i benefici della transizione energetica, consapevolezza indispensabile per favorire l’accettabilità degli impianti nei territori. A proposito della qualità della domanda elettrica è ormai urgente e non più rimandabile l’introduzione della cosiddetta “demand – response” che permetterebbe ai cittadini e alle imprese di risparmiare con un consumo più responsabile e concentrato nelle ore di maggiore produzione. In tal senso si sollecita sia l’Autorità che TERNA ad introdurre velocemente le norme necessarie per l’avvio della “demand- response”.
Marco Enrico Ricotti
C'è molto da fare sul versante culturale: certamente sul risparmio e sull'efficienza energetica, sulle abitudini nei consumi, ma pure nell'informazione sui temi dell'energia, troppo spesso improntata a scarse conoscenze tecnico- scientifiche, ad approcci ideologici e pregiudiziali, a discussioni da talk-show.
Un occhio ai brevetti
Senza pretesa di esaustività, abbiamo controllato le domande di brevetto depositate negli ultimi 10 anni grazie al supporto di Christian Vanzini, Partner - Italian and European Patent Attorney, Jacobacci & Partners Spa e di Maurizio Bonavita, Chief Paralegal, esperto in ricerche Brevetti.
Non è un dato oggettivo, ma può dare un’idea dell’interesse distribuito sulle singole tecnologie. «Abbiamo ipotizzato che i brevetti relativi alle centrali "piccole" riportassero i termini "modular" e "reactor" nel titolo, o almeno nell'abstract del brevetto» spiega Christian Vanzini. Per quanto riguarda le famiglie brevettuali comprendenti almeno una domanda di brevetto europeo, o una domanda di brevetto nazionale nei Paesi europei risultano complessivamente:
- 31154 famiglie di brevetti aventi classificazione attinente alle energie rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico, no nucleare),
- 6652 famiglie di brevetti aventi classificazione attinente all'energia nucleare (sia fissione sia fusione),
- 20 famiglie di brevetti relativi a reattori modulari (quindi piccole centrali).
*I dati dal 2023 in avanti non sono significativi a causa del periodo iniziale di segretezza di 18 mesi, previsto per le domande di brevetto.
Fonte: L' INDUSTRIA MECCANICA 741 | No 1 2025