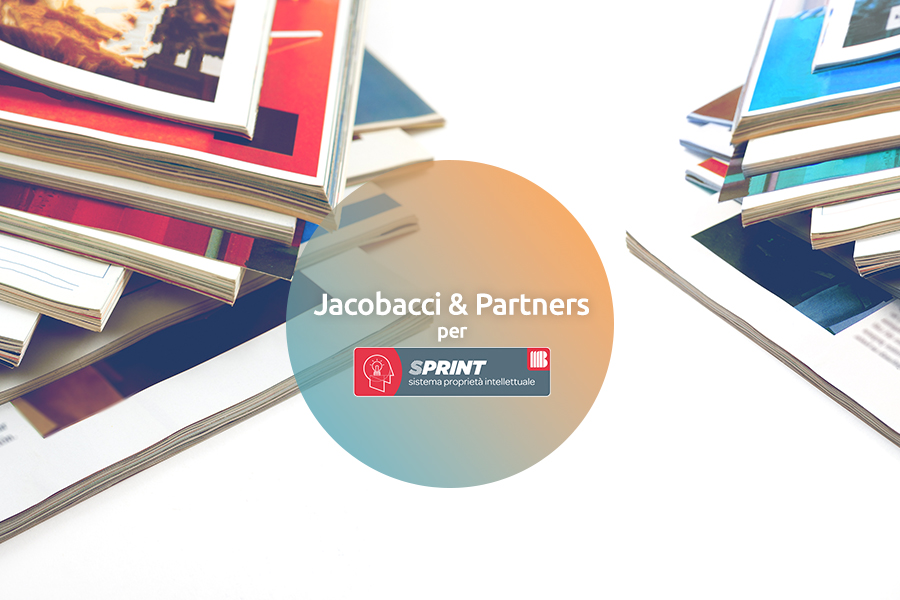Gabriella Gerosa intervista Miriam Mangieri per un articolo sull'anticontraffazione nel settore cosmetico pubblicato sulla rivista Imagine.
E' di fondamentale importanza vigilare sull'autenticità dei prodotti cosmetici in commercio. Ne va della salute del consumatore, ma anche del mercato, che viene impoverito e logorato dal proliferare di falsi. Cosa si sta facendo? L'abbiamo chiesto ad autorità ed esperti.
Un fatto è certo: nel beauty la contraffazione si espande perché si tratta di un mercato in forte crescita. E l'interesse economico è da sempre propulsore di attività illecite. Secondo i dati del Comando Generale della Guardia di Finanza, aggiornati al periodo 2022-24, nel nostro Paese sono stati eseguiti 439 interventi di sequestro, con il ritiro di 3.367.716 pezzi contraffatti tra cosmetici, profumi e prodotti per l'igiene e cura della persona, per un valore pari a 18.597.665 euro. «L'esperienza maturata nel tempo conferma che il fenomeno interessa tutti i settori produttivi: dal farmaceutico all'alimentare, dall'abbigliamento ai giocattoli e, naturalmente, alla cosmetica. Di frequente la merce viene importata e distribuita da associazioni criminali, anche di tipo organizzato, che utilizzano tecniche sempre più raffinate e ingannevoli», conferma il Tenente Colonnello Antonio De Cristofaro, Comandante della 1^ Sezione del Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti, del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. Ma come arriva nel nostro Paese? Come si contrasta il fenomeno e cosa dice la giurisprudenza in merito? E ancora, quali sono gli strumenti per difendere brand e consumatori dal propagarsi di questa pratica illegale?
Come (e dove) nasce il falso
Secondo i dati del Comando Generale della Guardia di finanza al 30 giugno 2024, «la Cina è il principale paese di provenienza dei cosmetici contraffatti sequestrati (54%, 906.980 pezzi), seguita dall'Italia (20%, 334.000 pezzi). Anche la Turchia è un Paese di origine della merce, insieme a India, Romania, Bulgaria e Ungheria», specifica il Tenente Colonnello Antonio De Cristofaro. «Inoltre, la Componente territoriale della GdF ha rilevato in Italia piccole fabbriche di produzione, etichettatura e confezionamento - gestite principalmente da cittadini di origine cinese e in misura minore da indiani e italiani - dove su prodotti 'neutri' vengono applicati segni identificativi e marchi registrati. Sono stati individuati anche depositi di stoccaggio in Campania (151.805 pezzi sequestrati), Lombardia (61.425 pz) e Sicilia (21.404 pz)». Ma attraverso quali modalità gli articoli falsi vengono acquistati? «Il commercio si sta spostando sempre più su marketplace e social network, piattaforme di messaggistica istantanea, forum online e altri tipi di chat. Un ulteriore modus operandi consiste nella creazione di siti web per la vendita di merce contraffatta, spesso clonati da quelli dei marchi, con foto degli articoli identiche a quelle ufficiali per indurre in errore gli utenti. In genere, i contraffattori scelgono di diversificare i canali utilizzati per massimizzare il numero di potenziali clienti raggiungibili ed eludere i controlli, sia delle autorità sia quelli automatizzati delle stesse piattaforme di e-commerce e social network, sempre più rigorosi. Proprio grazie al loro monitoraggio, la Guardia di finanza di Portici (Na) e di Ferrara ha recentemente individuato alcuni esercizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di cosmetici, e sequestrato oltre 2 milioni di articoli contraffatti».
Le strategie di contrasto
Tutelare la proprietà industriale, disincentivare all'acquisto di merce falsa, procedere al sequestro e alla ricostruzione della filiera illecita. Come si perseguono tali obiettivi? «Con il presidio delle aree doganali, portuali e aeroportuali, in sinergia con gli Enti competenti, e attraverso il controllo economico del territorio e l'attività investigativa. L'azione di contrasto si estende anche al web, con un monitoraggio che richiede collaborazione tra gli stakeholder del settore, anche a livello internazionale, perché non è agevole individuare chi si nasconde dietro i siti illegali e risalire ai luoghi di produzione e stoccaggio della merce», sottolinea il Tenente Colonnello De Cristofaro. «Un nostro valido strumento operativo è il SIAC (Sistema Informativo Anticontraffazione), gestito dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi: una piattaforma informatica accessibile al pubblico e alle realtà produttive, attraverso cui si sviluppa un'efficace cooperazione con Forze di Polizia, componenti istituzionali, aziende e associazioni di categoria. Fondamentale è anche la collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si concretizza nella Linea Diretta Anti Contraffazione (LAC), pensata per ricevere segnalazioni dai cittadini e attivare il Nucleo Speciale in caso di anomalie. In questa cornice si collocano le iniziative per rafforzare le partnership con le piattaforme di e-commerce, e creare modalità di individuazione dei bad actors, nonché le numerose operazioni di contrasto organizzate sotto l'egida delle principali Autorità di riferimento europee e mondiali. In ambito EMPACT (piattaforma europea contro i crimini transnazionali), per esempio, la GdF è stata co-leader nell'azione operativa 'Aphrodite': nel corso delle due ultime edizioni, la Componente territoriale del Corpo ha sequestrato oltre 26 milioni di prodotti contraffatti e/o pericolosi per la salute, tra cui anche cosmetici, profumi e articoli per la cura della persona».
La normativa è una tutela?
Fa chiarezza Miriam Mangieri, Partner Trademark Attorney di Jacobacci & Partners. «In Italia il riferimento è il Codice di proprietà industriale, che ha recepito i regolamenti europei e raccoglie le norme a tutela dei diritti immateriali (marchi, brevetti, design che possono essere oggetto di registrazione). Il Codice si integra con il Regolamento sui prodotti cosmetici dell'UE, il 1223/2009: che riporta indicazioni essenziali su definizione di cosmetico, tracciabilità, etichettatura… e su tutti quegli aspetti che i prodotti contraffatti non rispettano in parte o in toto, ostacolando i principi di trasparenza e responsabilità». Ciò che manca è una normativa specifica che applichi il concetto di proprietà intellettuale anche ai cosmetici. «Quindi, si procede per analogia e per precedenti giurisprudenziali, con le decisioni del Tribunale e della Corte di Giustizia dell'UE che aiutano a risolvere questioni critiche». Altra cosa è il diritto d'autore (L. 633/1941), continua Mangieri. «Nasce con la creazione dell'opera d'arte e non è richiesta una registrazione per ottenere tutela. Tuttavia fa riferimento a opere teatrali, letterali, musicali... ma non alle fragranze. Gli ostacoli? Sono di ordine pratico. Per essere tutelata dal diritto d'autore, infatti, un'opera deve essere tangibile e oggettiva. Il profumo, invece, è ritenuto un'esperienza soggettiva e la sua formulazione, sebbene frutto dell'idea di un creatore, viene considerata come applicazione tecnica di una serie di ingredienti». Come affrontare, dunque, il tema dell'oggettività? «A livello europeo si è provato con la descrizione verbale della fragranza, con il deposito di un campione, che però col tempo si deteriora. E persino con l'ipotesi di una classificazione internazionale degli odori, simile a quella che c'è per i colori. Ma esistono ancora lacune tecniche che non aiutano quelle normative».
Come si difende il cosmetico
Quando nasce un nuovo prodotto, quali sono le strategie da attuare per bloccare sul nascere tentativi di contraffazione? «Lo strumento giuridico di tutela della formula chimica è il brevetto, ma non è sempre una strada agevole. Vi si può ricorrere in presenza di un aspetto di novità, rispetto a quanto già registrato ed esistente, e soltanto prima della divulgazione della formula, altrimenti viene meno la possibilità di protezione», precisa Miriam Mangieri. «Alle aziende consigliamo quindi massima riservatezza e accordi di segretezza anche al loro interno. Inoltre, è bene registrare tutto ciò che è possibile: il nome, il packaging, il design, l'etichetta, il modo in cui si appone il marchio sulla confezione… ovviamente in presenza dei requisiti di novità e distintività». Uno degli strumenti più utilizzati dalle aziende attente ai propri diritti e alla proprietà intellettuale è il monitoraggio online: «Si basa su sistemi di intelligenza artificiale e permette di individuare prodotti falsi su social, piattaforme e-commerce, siti web generici. E poi di intervenire chiedendo la rimozione dei contenuti e la chiusura della pagina abusiva. Offline consigliamo il servizio di sorveglianza sui marchi, che consente di rilevare depositi di marchi identici o simili fatti da terzi, e la sorveglianza doganale, che porta a forte repressione, con il blocco e sequestro di interi lotti e successive cause contro i responsabili. E ancora, esistono efficaci tecnologie adottate dalle aziende per consentire la tracciabilità del prodotto e ridurre le violazioni: blockchain, QR code, codice a barre, etichette intelligenti...».
Aziende in prima linea
«L'adozione di nuove tecnologie da parte delle aziende è un'ottima opportunità per prevenire la contraffazione, perché rende possibile la ricostruzione dei flussi commerciali lungo la catena produttiva, logistica e distributiva», osserva il Tenente Colonnello De Cristofaro, sottolineando la necessità di una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni e titolari dei diritti. Come rileva Miriam Mangieri, infatti, «i grandi Gruppi del lusso investono molto nella difesa della proprietà intellettuale e di fronte a violazioni procedono fino a rivolgersi alle autorità più alte». Non solo. LVMH, per esempio, ha lanciato, insieme a Prada Group, OTB e Richemont, Aura Blockchain Consortium, una piattaforma che sfrutta la blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità, proteggere i marchi e dare ai consumatori informazioni affidabili. Da luglio 2025, con l'ingresso di Amouage, è attiva anche nel settore beauty. Tra i grandi marchi, Chanel vigila costantemente su siti, social network e marketplace, e collabora con polizia, dogane e piattaforme online contro gli illeciti. Quest'anno ha introdotto l'e-logo 'Authorized Retailer', che appare sui siti di rivenditori autorizzati di profumi e cosmetici, e serve a orientare il consumatore ostacolando la diffusione di falsi online. Anche la profumeria artistica ha un forte interesse a proteggere l'unicità dei prodotti. «Ogni fragranza che creo è il risultato di un percorso di ricerca autentico, profondo e artigianale. Per questo la contraffazione non è solo un danno economico, ma un furto d'identità», sottolinea Fabrizio Tagliacarne, Founder & Fragrance Designer di Omnia Luxury Trade. «Abbiamo quindi scelto di investire in una strategia di contrasto lungimirante, che parte dalla registrazione di marchi, loghi e design del packaging, e continua sul Cosmetic Products Notification Portal, creato dalla Commissione Europea per garantire sicurezza e controllo dei cosmetici sul mercato. Inoltre, puntiamo su un design esclusivo e raffinato, su materiali o tecniche di stampa difficili da replicare. E ancora, su dettagli identificativi, come incisioni, elementi numerati o texture brevettate».
Nuove tecnologie crescono
La nuova frontiera della contraffazione va oltre il fake. «Ormai, i profumi vengono 'clonati' attraverso l'uso di macchinari capaci di indicarne la composizione: gli stessi che noi adoperiamo per garantire ai clienti qualità e standard continuativo del loro prodotto», afferma Luca Maffei, Ceo e Perfumer di Atelier Fragranze Milano. «Il mercato europeo dei falsi vale oltre 4 miliardi e vengono sequestrati due-trecento milioni all'anno di pezzi. Quindi è sempre più urgente intervenire. Purtroppo, da un punto di vista giuridico non esiste modo per proteggere la proprietà intellettuale di una fragranza perché manca il presupposto, cioè non è considerata arte. In realtà, esistono sentenze europee pregresse sul tema, ma non sono mai stati applicati i requisiti di brevettabilità (novità, originalità, applicabilità industriale)». Partendo da queste riflessioni, Maffei e Alberto Asti, Ceo e founder di IT Value Partner, hanno dato vita ad AIDA (Authored Intangible Digital Assets), una piattaforma per la tutela delle creazioni olfattive e la certificazione dell'autenticità dei profumi. «In AIDA è possibile registrare le formule (abbiamo censito oltre il 90% delle materie prime), la paternità, la scheda tecnica, il numero di pezzi creati; ma anche i passaggi della catena produttiva e persino le certificazioni e le transazioni dei lotti», racconta Maffei. Un passaporto digitale del prodotto a tutti gli effetti. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Spiega Alberto Asti: «AIDA si avvale della tecnologia blockchain per creare una registrazione permanente e a prova di manomissione di formule di profumi o cosmetici, incorporata in un NFT (Non-Fungible Token): bene digitale irriproducibile, che garantisce unicità, autenticità, proprietà e paternità della creazione. Per l'utente finale il sistema è semplicissimo. Basta avvicinare il cellulare al prodotto per collegarsi, tramite un chip (NFC: Near Field Communication) applicato sul packaging interno, a una pagina web e visionare il certificato di autenticità che contiene l'intera 'storia' del profumo. Si tratta di un sistema di tutela che ha anche una funzione educativa sul consumatore finale, stimolato a riconoscere il valore dell'autenticità e i rischi della contraffazione».
La frontiera della sicurezza
Fra le tecnologie più all'avanguardia c'è un sofisticato sistema integrato anti-contraffazione collegato all'IA, che restituisce ai brand di alta gamma il controllo sulle proprie creazioni anche dopo la vendita. Si chiama KOBRION e nasce dalla sperimentazione avviata da Stefano Torreggiani e Davide Martini, founder di Rito, marchio di profumeria artistica che si propone di essere un omaggio al lusso e all'innovazione non solo dal punto di vista olfattivo e del design, ma anche dei meccanismi di tutela del prodotto. «Il sistema è l'evoluzione di Rito-Security, da cui siamo partiti, e rappresenta la nuova frontiera della sicurezza», racconta Torreggiani. «Una sua parte funziona attraverso il 'contatto' tra l'NFC nascosto dietro l'etichetta del profumo e il cellulare, che permette di atterrare sul sito della Casa madre (non sul dominio KOBRION). Al termine della procedura prevista si riceve un certificato ufficiale univoco e non replicabile: la prova che l'articolo è autentico e proviene da un punto vendita autorizzato». Non solo: «Stiamo parlando di un programma blindato, che tutela l'identità di qualsiasi tipo di prodotto con un sistema crittografato. Ogni volta che viene attivato, può testare la legittimità del soggetto che ha agito, anche grazie a geolocalizzazione e riferimenti temporali. Inoltre, associa codice seriale e fattura. Ciò significa totale tracciabilità, monitoraggio in tempo reale delle violazioni e persino lotta al 'mercato grigio', causa di danno reputazionale alle aziende». Ma qual è la sua forza e in cosa si differenzia davvero? «L'utilizzo del sistema prevede l'inserimento di una email, che va ad alimentare un database di clienti autenticati, prezioso per costruire una relazione diretta tra brand e pubblico. Inoltre, aspetto non secondario, molti sistemi basati su QR code o NFC possono essere copiati o replicati. KOBRION no, perché è progettato per impedire attacchi informatici, accesso automatico o duplicazione massiva».
Il selettivo a difesa del consumatore
La distribuzione selettiva è cruciale per sensibilizzare il consumatore ed educarlo alla qualità. «Una rete di vendita ben selezionata è fondamentale», spiega Tagliacarne. «E ogni brand di profumeria artistica dovrebbe non solo monitorare le piattaforme online per individuare presenze sospette, ma anche limitare la vendita a soggetti autorizzati, meglio se condividono la visione del brand. Ciò riduce il rischio di 'contaminazioni'». Oltre a essere una garanzia, il selettivo è uno sportello di consulenza. «Tanti si rivolgono al personale dei negozi dopo essere caduti in trappola, spesso inconsapevoli che i cosmetici contraffatti possono avere ripercussioni su salute e sicurezza», sottolinea il presidente di Fenapro, Michelangelo Liuni. «E anche se la nostra categoria da sola non può fare molto, di fronte a un problema di questa complessità, cerchiamo di informare i clienti, aiutandoli a distinguere il vero dal falso. Segnaliamo che i cosmetici contraffatti, tra le caratteristiche comuni, hanno un prezzo insolitamente 'scontato', confezioni di bassa qualità, a volte con errori di ortografia e prive di informazioni chiave come il numero di lotto. Inoltre, suggeriamo di acquistare -online e offline- solo da fonti affidabili. Una di queste è proprio la profumeria selettiva, che mette a disposizione consulenti qualificati, focalizzati sulle esigenze specifiche del cliente per offrire un'esperienza di acquisto unica. E che ha un impatto positivo sulle scelte consapevoli dei consumatori».
Più collaborazione e informazione
Le aziende possono investire tanto, ma se i consumatori non sono edotti e consapevoli, gli sforzi vengono vanificati. Lo pensa Miriam Mangieri, che ribadisce la fondamentale importanza di campagne di sensibilizzazione «per sottolineare la pericolosità dei fake e per dire a chiare lettere che acquistare prodotti contraffatti danneggia l'economia e l'occupazione». Insomma, un cliente informato diventa un alleato nella lotta alla produzione e al commercio illegale. «I brand dovrebbero preoccuparsi di comunicare il pregio dell'autenticità, per aiutare le persone a fare scelte giuste, rafforzando il valore percepito del brand», aggiunge Tagliacarne, che continua: «Attraverso i nostri canali digitali, ci impegniamo a raccontare il dietro le quinte di una creazione olfattiva, la complessità della formula, il tempo impiegato a rifinire ogni accordo. Perché solo conoscendo si può riconoscere». Ovviamente, le istituzioni hanno un ruolo fondamentale. Conclude il Tenente Colonnello De Cristofaro: «La priorità è sì far capire ai cittadini di non acquistare prodotti contraffatti ed evitare canali di vendita non autorizzati, ma altrettanto rilevante è segnalare la merce falsa alle autorità competenti. In questo senso si collocano le tante iniziative formative promosse dalla Guardia di Finanza anche presso le scuole. La lotta contro la contraffazione è una sfida complessa che richiede un impegno collettivo. Solo attraverso la collaborazione tra consumatori, imprese, istituzioni e autorità competenti possiamo sconfiggere questo nemico subdolo e costruire un futuro migliore per tutti»
Come si distingue il falso dal vero?
Se l'obiettivo della contraffazione è riprodurre il prodotto originale in tutte le sue possibili caratteristiche, esistono sempre alcuni elementi di dettaglio che consentono di distinguere il falso dall'originale. Come sottolineato dal tenente colonnello Antonio de Cristofaro, Comandante della 1^ Sezione del Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti, del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza
«Il prezzo è sicuramente un indicatore: se è troppo basso rispetto a quello dell'originale presente sul mercato, bisogna insospettirsi. Altri elementi da analizzare sono la qualità del packaging o del vetro del flacone (più leggero, fragile o con bordi irregolari in caso di fake), l'assenza del sigillo di sicurezza o della pellicola protettiva che hanno spesso i profumi originali per garantire l'integrità del prodotto, e il fatto che il rivenditore non sia autorizzato dalla Casa madre. Inoltre, in caso di prodotti contraffatti, verificando il numero del lotto (se presente) sul sito ufficiale del marchio non si trova alcuna corrispondenza. Anche il codice QR può aiutare, perché una volta inquadrato non reindirizza ai siti web ufficiali delle Case produttrici. Altra tecnica di 'camouflage' è quella di sovrapporre nuove etichette adesive alle precedenti. Lo scorso maggio, la Guardia di finanza di Cosenza ha sequestrato 33.000 etichette di diverso colore - su cui era stata omessa l'indicazione delle sostanze chimiche vietate - che venivano utilizzate per rietichettare i prodotti cosmetici. Ultimo, ma non meno importante, è il fenomeno della vendita dei tester, diffuso soprattutto nell'e-commerce: operazione illecita in cui gli sconti praticati dai rivenditori vanno dal 40 al 50% rispetto allo stesso prodotto venduto nel mercato. Se non si tratta di tester contraffatti (per i quali si applicano le norme penali), ma originali, la Guardia di Finanza verifica che non provengano da furto o non derivino da una produzione che supera i limiti definiti dagli accordi commerciali tra la Casa madre titolare del diritto di proprietà industriale e il fabbricante (il cosiddetto over running)».
Contributo di Miriam Mangieri, trademark attorney presso la sede di Roma della Jacobacci & Partners, per la rivista Imagine